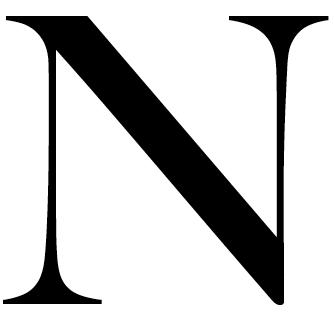THAT THING THAT NEVER VANISHED
EMANUELE SATOLLI
Intervista a cura di Riccardo S. D'Ercole
Fotografie di Nicola Colia
Abbiamo intervistato Emanuele Satolli, fotografo, e Angelo Castucci, curatore, in occasione dell’apertura della mostra That Thing That Never Vanished, allestita negli spazi di Assab One a Milano.
That Thing That Never Vanished è un titolo-contenitore che racchiude la mostra e il libro che hai pubblicato con Gost. Che cos’è questa cosa che non è mai scomparsa?
E.S.: Nelgi ultimi settant’anni, specialmente in occidente, ci siamo quasi illusi che stavamo vivendo in un mondo di pace, ma in realtà la guerra non se n’era mai andata. Questa cosa che sembra innominabile è la guerra. Il libro, ma anche la mostra, sono stati studiati e pensati in base a questa idea fondamentale che sorregge tutto il progetto. Ci sono foto di Gaza, poi si passa all’Iraq, c’è l’Ucraina, l’Afghanistan, la Turchia, la Libia e si ritorna a Gaza. È un continuum che ha a che fare con questa «cosa» che in realtà c’è sempre stata. Ora a noi, forse di più con l’invasione russa che è avvenuta proprio nei confini europei, sembra che la guerra si sia avvicinata, ma in realtà la guerra non se n’è mai andata. In questo ambito ci metto anche il fatto di riproporre alla condizione umana un’esistenza che deve fare i conti sia con la reale possibilità di morire sia con la reale possibilità di uccidere. C’è anche la domanda che uno si potrebbe porre: sono io totalmente immune da questa reale possibilità di uccidere? Con questo progetto volevo restituire delle riflessioni che ho prodotto negli anni coprendo i conflitti; le due riflessioni principali sono queste.
La prima:
Mi è capitato di vedere civili che poi sono stati giustiziati e sapevano che stavano per morire, oppure soldati che avevano ben presente che stavano per ricevere un ordine o per svolgere una missione molto pericolosa. Vederli lì, in quel momento prima dell’azione, e pensare che loro stavano considerando la reale possibilità di morire, mi ha devastato. Freud diceva: tutti dobbiamo morire, ne siamo tutti consapevoli, ma nella vita di tutti i giorni è come se non ci dovesse accadere. Lo stesso Freud sosteneva che in guerra ci devi credere, devi iniziare a credere che tu possa morire, e questo credere, il dover credere al fatto di poter morire, è una cosa che secondo me è devastante. Questo è un punto.
L’altro punto è l’opposto: riguarda la reale possibilità di commettere il male. In mostra abbiamo esposto le foto del miliziano dell’Isis che viene portato via dai soldati iracheni. Sembra lo specchio di una foto che era stata fatta sette mesi prima all’inizio dell’operazione per liberare Mosul, quando l’Isis pubblicava video su video di civili iracheni – erano diventati famosi con questi video per l’atrocità che hanno sempre mostrato. Dopo nove mesi la situazione si è specchiata: erano i soldati iracheni che erano atroci nei confronti dei miliziani dell’Isis. Me lo sono chiesto molte volte, perché io sono cresciuto in un mondo in cui mi preoccupavo di seguire una morale, di difendere l’etica, il rispetto, e mi sentivo molto un «chierichetto». Dopo queste esperienze mi sono ritrovato a chiedermi: sarei capace, io, di uccidere qualcuno? Forse sì, ma non è che o ce l’hai o non ce l’hai, secondo me. È un seme che è dentro, che può venire fuori a seconda delle circostanze. Quei soldati hanno vissuto nove mesi in bilico tra la vita e la morte (i soldati iracheni nella battaglia di Mosul n.d.r.); è stata una battaglia sanguinaria, si svegliavano al mattino spaventati, combattevano, il compagno gli moriva di fianco, l’altro rimaneva ferito, poi dopo nove mesi di esistenza in quelle condizioni prendi tra le mani un essere umano che è il tuo nemico… Credo che probabilmente anche io sarei capace di uccidere se vivessi in determinate condizioni (si riferisce a un meccanismo di empatia e di logica speculativa n.d.r.). Questa è una riflessione che abbiamo voluto mantenere chiaramente nella mostra e nel libro: il fatto che è questa la cosa che non se ne è mai andata… Siamo qui a pensare che la ragione, il progresso della ragione, ci porterà la pace. Ne siamo sicuri? A me non sembra. E questo libro è un po’ una testimonianza. Che c’è una cosa che non se ne è mai andata, che è questo segno del male, che è la guerra che continua, nonostante questo presunto progresso della ragione. Continuiamo a mettere le persone di fronte a questa terribile situazione che è la reale possibilità di morire e di uccidere.

«È un continuum che ha a che fare con questa "cosa" che in realtà c'è sempre stata. [...] C'è una cosa che non se ne è mai andata, che è questo segno del male, che è la guerra che continua, nonostante questo presunto progresso della ragione.»


È una riflessione che ha a che vedere con le grandi narrazioni sorte nel secondo dopoguerra, con l’avvento dell’idea di un mondo che non possa mai più lasciar accadere atrocità come quelle della metà del Novecento.
E.S.: Sì, l’idea della «fine della storia», no? Proprio quello. Il racconto secondo cui era stato tutto equilibrato e che in quell’equilibrio avremmo vissuto e saremmo stati felici di essere qui per sempre. Ma non è così, perché ci sono degli equilibri nuovi che si determinano adesso. Basti pensare alla corsa all’accaparramento delle risorse: abbiamo bisogno di quelle risorse, la produzione tecnologica per sopravvivere necessita di risorse. E per ottenere quelle risorse bisogna prevalere in alcune parti del mondo. Questa cosa non se ne andrà mai. È bello credere nella pace, siamo tutti operatori di pace perché altrimenti non avremmo realizzato questa mostra e questo progetto. È per parlare di guerra, ma per cercare di sensibilizzare sulla pace, certo. Però io sono un po’ scettico (non sull’effetto di questa mostra e delle fotografie), sul concetto stesso di pace, sulla stessa condizione di pace che è un equilibrio molto precario; uno stadio come di una camera di decompressione tra un conflitto e l’altro.
Pensi che laddove non sia un dispositivo concreto e attivo si tratti di una mera astrazione, possiamo dire, demagogica?
E.S.: Sì, più che una astrazione è un insieme di forze che hanno un equilibrio precario e che collassano lasciando spazio al caos successivo. Stiamo calmi per un po’ per iniziare un altro caos subito dopo, ancora e ancora.


Guardando la mostra e il libro, seguendoti da qualche anno, ci si rende subito conto che That Thing That Never Vanished tiene insieme quasi tutta la tua attività di fotografo e di reporter. Mi chiedevo se ritenessi questo libro e la mostra un punto di svolta, un punto di arrivo, o se si tratta di qualcosa che vi sembrava naturale come sbocco di un processo professionale e creativo.
E.S.: Faccio un po’ fatica a dire che questo è il lavoro dei miei ultimi dodici anni, perché sembra quasi una monografia, ma non sono maturo abbastanza per una monografia. A una monografia si deve arrivare in un tempo più lungo. Passati dodici anni da quando copro i conflitti, ho notato che c’è un filo conduttore che abbiamo provato a restituire non inserendo nei capitoli e nei luoghi nessun ordine cronologico; c’è un filo conduttore che non se ne andrà mai, appunto. Non è una monografia. Sto riflettendo molto su quello che faccio anche perché ho iniziato che avevo un’età e ora ne ho un’altra e quindi – lo dico e spero di riuscirci – vedo un po’ questo progetto come un passaggio a una fase successiva. Sarebbe bello e vorrei che questa fosse non proprio una chiusura totale, perché continuerò sicuramente a seguire conflitti, ma che fosse magari una riflessione per scoprire un linguaggio fotografico diverso, soggetti diversi o gli stessi soggetti letti attraverso un filtro diverso, attraverso una riflessione nuova. Sì, sicuramente vorrei cercare di confezionarmi un ambito un po’ divergente da questo e quindi lo sto vedendo come la chiusura, non totale, di una fase e il passaggio a qualcosa di un po’ differente, come una sorta di metamorfosi personale e professionale. Sicuramente è difficile ma è quello che vorrei fare.

Mi sono reso conto che avete dato ampio spazio al racconto testuale e personale. Non è qualcosa che ha, come di solito si tende a fare, uno spazio marginale o esplicativo, didascalico, ma è qualcosa che comunica e dialoga in maniera molto forte con l’allestimento e con le immagini. C’è molto testo, è quasi come se fosse un racconto che accompagna tutta l’esposizione.
E.S.: Abbiamo ragionato molto su come presentare le fotografie, sul modo in cui posizionarle. È stato fondamentale dare un’idea di non-linearità. Nel fotogiornalismo la didascalia che accompagna la foto è molto importante, ma spesso è solamente descrittiva. Nel caso della mostra, invece, entri, c’è la foto di Gaza, poi vai a destra, c’è l’Ucraina, dietro ancora c’è l’Afghanistan, poi c’è l’Iraq; insomma si passa da un luogo all’altro, però poi ci sono le miniserie, nella stanza (Assab One, primo piano, stanza a cui si accede dalla sala principale dove è allestita la mostra di Emanuele Satolli n.d.r.) c’è tutta la miniserie dell’Ucraina; oppure ci sono la serie dell’Iraq e delle donne che scappano tra le macerie. Abbiamo sentito che era importante contestualizzare di più, e contestualizzare non solo sull’accadimento specifico successo questo o quel giorno, ma farlo anche in maniera più personale. Alla fine quello che mi dicono le persone quando visitano la mostra è che sono molto colpite dal fatto che si capisca che sono stato lì, testimone ravvicinato di quel fatto. «La cosa che mi impressiona molto è pensare che tu sia stato lì.» Anche mia mamma una volta, dopo aver visto delle mie immagini, mi ha chiesto: «Ma tu eri lì?». «Ma l’ho fatta io la foto, certo che ero io» le ho risposto.
Il testo ha aiutato molto a dare questo senso della mia presenza nelle varie situazioni e sono testi che secondo me sono azzeccati non per come sono scritti, ma per la scelta con cui sono stati inseriti nel percorso espositivo. Aiutano moltissimo nella ricostruzione di un viaggio e nella visita della mostra.
A.C.: Il fatto di introdurre queste piccole storie nella non-linearità di questa mostra – che comunque è costituita da una successione di immagini tra di loro apparentemente non contestualizzate (o immediatamente contestualizzate) – di inserire questi racconti, era un modo di innestare queste piccole storie dentro a questa non-linearità di cui abbiamo parlato. I testi diventano un po’ come un’intelaiatura narrativa della mostra, tengono tutto insieme con questi racconti, come diceva Emanuele, anche molto personali, molto diretti, con un linguaggio quasi da diario, da racconto intimo. Era interessante per noi lavorare sulla modalità di inserimento di queste serie dentro al flusso di immagini. E in alcuni punti la didascalia, che di solito è una cosa «appiccicata» lì nell’angolo, diventa proprio strutturale nella conformazione della mostra. Penso ai due pannelli di cartongesso con poliuretano che reggono delle storie. Il racconto che è messo di fianco fa parte dell’insieme che tu stai guardando: non guardi solo la foto, ma guardi tutto, vedi l’insieme. All’inizio ci eravamo interrogati sul fare un foglio di sala, se inserire i testi o non inserirli affatto. A un certo punto invece siamo ripartiti da queste storie che diventano, come dicevo, un’impalcatura generale narrativa di tutta la mostra. Tornando a quei pannelli, la mascherina di fianco fa parte anche a livello estetico della foto, non è una cosa attaccata lì ed estranea, ma è un elemento integrante che è nella parte posteriore del pannello. Era necessario: quelle foto sono legate a doppio filo con il proprio racconto testuale.

Collegandoci a quanto stavi dicendo ora ti andrebbe di descrivere il criterio curatoriale utilizzato per l’esposizione? Conosciamo l’interesse che studioamatoriale ripone nella ricerca sui materiali: sappiamo che per voi non si tratta di semplici «muri» dove si espone, ma è ben visibile, anche in questa mostra, la ricerca che avete fatto con Emanuele per innestare le immagini su dei veri e propri supporti che agiscono come dei dispositivi narrativi.
A.C.: Da un punto di vista curatoriale il lavoro è stato svolto insieme a Giulia Tornari, che è con me la curatrice della mostra. Il principio generatore è stato quello di costruire un’esposizione non-lineare e non-cronologica, slegata dai particolari conflitti e non geolocalizzata, immaginare un’esperienza di attraversamento del lavoro di Emanuele e del concetto stesso di guerra. Naturalmente l’allestimento, cioè il disegno del display della mostra, ha che fare con quello che stiamo dicendo, ma anche con lo spazio in cui ci siamo trovati, che è Assab One: uno spazio ex-industriale. Non è un white cube, non ha pareti bianche. È uno spazio interessante e al contempo complesso da allestire. Lavorando con l’autore, chiedendoci come poter esporre questo lavoro senza «spiattellarlo» – cioè rendendo anche l’esperienza della visita un’esperienza che richiedesse un suo tempo e uno spazio di distanza e di vicinanza dalle sue foto – siamo arrivati a progettare queste microarchitetture che costruiscono degli ambiti narrativi e di prossimità al lavoro di Emanuele. Sono degli elementi architettonici che toccano il concetto di domestico, come se fossero dei pezzi di interni che puoi solcare con delle porte aperte, che ti permettono di passare da un certo tipo di visione a un’altra attraversando la parete espositiva. È seguito il discorso sul materiale, su come rendere la fruizione di queste fotografie. Sono delle immagini estremamente forti e terribili da guardare. Si è fatto un tentativo di accoglierle in un ambiente più caldo, più intimo. Abbiamo scelto il legno, il colore giallo, un colore caldo ampiamente utiizzato nel visivo. È associato al pericolo, il giallo, anche a quello, ma dall’altro lato può essere associato anche alla nostra cultura pittorica occidentale: è il colore che si usa per le scene sacre. Quello che vediamo nelle foto di Emanuele spesso riguarda dei momenti di sacralità, dei momenti in cui una persona perde la vita, muore. Sei al suo funerale, sei lì e scatti quella foto in un momento sacro per la sua famiglia. È un momento di umanità che dilaga in maniera sacra. Per i pannelli c’era la questione della decisione molto forte di Emanuele di costruire una mostra su formati diversi e quindi di mostrare il lavoro fotografico su supporti diversi. Ciò per sottolineare ancora di più questa eterogeneità del lavoro, del percorso che si può esperire. Si è optato per il blue back, il Dibond, per incorniciare alcune immagini e non altre, per costruire questo trittico finale che un po’ traghetta lo sguardo di tutta la mostra; e lavorare con dei materiali apparentemente lontanissimi da una mostra fotografica: il pannello di cartongesso accoppiato al poliuretano richiama la costruzione domestica, quei pannelli servono per isolare le case. E quel materiale di solito è invisibile, nell’architettura non lo vedi perché sta in una facciata ricoperta dall’intonaco e l’altra sta all’interno del muro. È un materiale normalmente nascosto che noi abbiamo portato in uno spazio espositivo. Questa rivelazione del materiale ha sempre a che fare con quel concetto di cui parlavo prima di costruire dei pezzi di casa, rotti, aperti; è una delle conseguenze della guerra: distruggere il domestico, l’intimo delle persone, lo spazio personale che queste vivono. Anche la presenza di questo grande tavolo (che è lungo dieci metri) è ascrivibile in questo ragionamento, perché la mostra naturalmente nasce come secondo step rispetto alla prima intenzione di Emanuele, che era quella di costruire un libro sulla guerra. Si tratta di un libro e non di un catalogo. La mostra viene dopo, ma non per importanza: è una mostra costruita attorno a questo libro. Una delle domande era: come si espone il libro in questa mostra? Ne mettiamo dieci, uno, non ne mettiamo nessuno? Allora abbiamo pensato a questo tavolo molto lungo su cui c’è questo libro esploso, aperto, non cucito, insieme ad altre piccole foto che non sono esposte e raccontano un altro lato della guerra che è quello che riguarda le conseguenze dei conflitti sugli spazi, non solo sulle persone, ma anche sulle città, sulle strade. Ci sono queste piccole foto di luoghi e anche in questo frangente c’era questa idea di costruire un tavolo un po’ incerto, questa cassettina aperta e un po’ instabile: è in piedi ma sembra che possa cadere da un momento all’altro.


Nel testo iniziale che descrive la mostra, c’è una frase che mi ha colpito e che cito testualmente: «Uno sguardo che coniuga rigore documentario e responsabilità etica». (Dal testo introduttivo della mostra di Giulia Tornari n.d.r.) Può appunto la fotografia, una fotografia che abbia un orizzonte documentario, essere un linguaggio che tenendo insieme documentazione rigorosa e artificio decodifica una realtà così difficile da leggere e decostruire, così stratificata? In che modo ti ritrovi in questo orizzonte?
E.S.: Spesso mi chiedono se c’è una foto singola a cui sono particolarmente legato. Sicuramente ce ne sono alcune, però io credo che una singola foto non riesca a risolvere completamente la questione del documentare. Sono orientato verso un corpo di lavoro, quindi secondo me anche il lavoro documentarista del fotogiornalista non si risolve in una singola immagine. Spesso, quando scatto, sento una certa responsabilità. Sto producendo dei documenti che possono essere utilizzati da ricercatori e da storici: non si tratta della semplice cronaca di quello che sta succedendo. Se faccio una foto a una barca di migranti, da quella foto si possono contare anche quanti sono. Già solo il fatto di poterli contare uno a uno è un dato scientifico. Da un punto di vista documentaristico credo che abbia un valore molto importante, sento questa responsabilità di essere il più attento possibile quando faccio questo lavoro, senza troppa approssimazione, perché l’approssimazione nella documentazione, nella fotografia documentaristica, non esiste, non c’è e non ci deve essere. Ovviamente ne consegue un discorso che riguarda gli aspetti estetici della fotografia. Sono attento all’inquadratura, se posso sono attento alla luce, eccetera. Alla fine c’è questa decodifica della realtà che rientra un po’ più nell’astrazione. Perché è vero che sto documentando, però la foto ha effetto se non ti restituisce l’intero, se è una foto che non svela tutto. La foto centrale del trittico, del semaforo, è una foto vuota, non c’è niente, però tu lo senti che lì c’è stato un caos tremendo poco prima: le truppe russe erano lì fino a poche ore prima. Cerco sempre di essere il più preciso possibile con la documentazione, e di astrarmi anche il più possibile quando si deve arrivare a ciò che non definirei «effimero», a una componente non troppo lapalissiana, non troppo palese.
Si può dire che tu sia uno dei pochi che lavora in questo senso nel tuo mestiere?
E.S.: Secondo me c’è il fotografo delle grandi agenzie come Reuters, Afp o Associated Press, che svolge un lavoro molto diretto perché deve scattare foto che devono funzionare per i giornali. Spesso la stampa, se ha a disposizione una singola immagine, cerca quella più chiara, più immediata. Io ho la possibilità e la fortuna di lavorare su progetti più lunghi, non ho l’esigenza di fare una foto e pubblicarla nel momento stesso, come fanno loro; in quel caso riesco ad astrarmi molto di più e a cercare di produrre un senso più personale. Tu guardi la foto e senti dentro di te che è più evocativa. Cerco di evocare qualcosa, ma quel qualcosa non so dirti cos’è perché è molto personale. È un’evocazione che deve scaturire dal non essere troppo diretti, forse.
Questa è una domanda aperta, può essere una riflessione: è la prima volta che abbiamo assistito a un crimine contro l’umanità, a un genocidio che continua ad avvenire sotto gli occhi di tutti, e si può dire che ci sia una documentazione, quella videografica o fotografica, che viene trasmessa a tutto il mondo quasi in contemporanea. Senti che ci sia una differenza di fondo tra quel tipo di documento e quelli che produci nel momento in cui copri un conflitto?
E.S.: Io credo che adesso gli israeliani e il loro governo sappiano benissimo che c’è un lavoro documentario condotto da professionisti che è molto rigoroso e al quale viene data forse una certa importanza. Di fatto vietano totalmente l’ingresso dei giornalisti sul campo, quindi tutto quello che esce sono soprattutto video, prodotti con il telefono, anche da bravissimi giornalisti locali. Però credo che questa nostra bulimia delle immagini online ci porti poi a screditare un po’ quelle immagini, quasi a non crederci totalmente. Nel giornalismo si crea un contratto tra giornalista e lettore e quindi quel contratto porta a un gradino appena superiore di autenticità. Non che le altre immagini che riceviamo siano false, vanno verificate, certo. Però se si crea questo contratto di stima con un giornalista o con un fotografo, tu sai che quello che ti fa vedere non ha bisogno di ulteriori verifiche. Questo lo sanno benissimo il governo e l’intelligence israeliani, tant’è che non fanno entrare giornalisti estremamente riconosciuti nella loro posizione, nella loro integrità, anche morale. Perché se entra la Cnn e ti fa vedere i bambini che stanno morendo ha un effetto più forte, perché è più difficile da smontare. È più facile smontare un video fatto da un palestinese che è all’ospedale, nonostante sia vero, nonostante tu veda delle persone morire. Questa è una componente importante, nel senso che il genocidio a cui stiamo assistendo è un genocidio purtroppo messo in atto da un paese che è bravissimo nella gestione del potere: potere mediatico, potere di influenzare altri paesi – purtroppo riescono a farlo perché sono molto capaci nella gestione del potere e all’interno della gestione del potere c’è anche la gestione della comunicazione – sono molto bravi in questo.
A.C.: Abbiamo parlato di questo molto a lungo durante il processo di costruzione della mostra e l’unica cosa che aggiungerei rispetto a questo è che credo molto nel valore educativo e didattico di operazioni tipo quella che abbiamo fatto; quindi è importante dire che questa mostra ha anche un aspetto di apertura alle scuole. Ospiteremo nelle prossime settimane vari licei, che saranno accompagnati da Emanuele a vedere il lavoro. È importante. Sicuramente è una mostra che può educare lo sguardo e educare anche il posizionamento che possiamo avere non solo quando guardiamo quelle immagini, ma anche rispetto a quello che sta accadendo. Quindi forse questo è un aspetto importante di un lavoro, di una mostra, di questo tipo.
Dal 10 ottobre all’8 novembre Assab One ospita la mostra That Thing That Never Vanished, dedicata al lavoro fotografico di Emanuele Satolli e accompagnata dall’omonimo libro pubblicato da Gost Books.
La mostra, realizzata da Zona e Gramma Studio grazie al contributo di Fondazione Cariplo e al supporto di Fondazione Carifac, in collaborazione con Laboratorio Lapsus, Assab One e studioamatoriale, presenta oltre dieci anni di reportage fotografici realizzati nei principali scenari di conflitto e crisi umanitarie contemporanei.